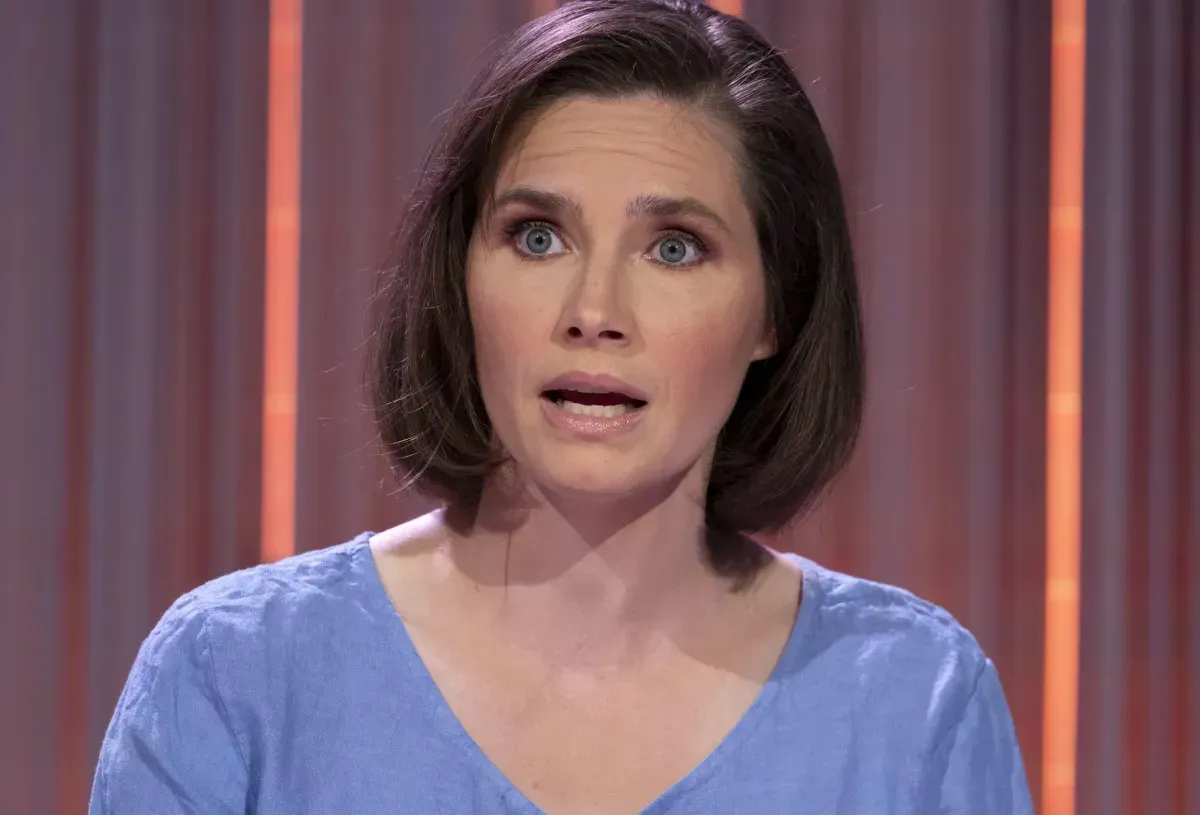
Un’apparizione nel podcast Goop di Gwyneth Paltrow, online dal 17 settembre, è bastata per rimettere Amanda Knox al centro del dibattito pubblico. L’attivista americana – assolta nel 2015 per l’omicidio di Meredith Kercher e nel 2025 condannata per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba – torna a raccontare la propria esperienza, ma è soprattutto il contesto a far discutere: un palcoscenico globale dove storytelling, marketing e intimità si intrecciano, e il confine tra testimonianza e spettacolo si assottiglia fino a sparire.
Nel dialogo con Paltrow, Amanda Knox pronuncia la frase destinata a essere ricordata per molto tempo: "Io e Meredith eravamo entrambe vittime delle stesse circostanze". A questo aggiunge: "Le persone hanno sempre cercato di metterci l’una contro l’altra in modo orribile", rivendicando la condizione di due studentesse straniere in Italia, "semplicemente due ragazze che volevano studiare" in un Paese che non era il loro.
È il cuore del dissidio: negli Stati Uniti il frame prevalente è quello dell’errore giudiziario, in Italia e nel Regno Unito resta aperta una faglia emotiva che tocca Perugia e la memoria collettiva di Meredith Kercher, la cui storia non può essere compressa in una formula narrativa comoda.
Knox ripropone anche le critiche all’avvio dell’inchiesta: "I miei diritti umani non sono stati rispettati. Non ho avuto supporto legale e le mie dichiarazioni non sono state registrate. Gli inquirenti mi dicevano che non ero indagata, per loro ero solo una testimone". In controluce sta la cronologia ormai scolpita: assoluzione definitiva nel 2015; unica condanna per calunnia nel 2025; per l’omicidio l’unico condannato resta Rudy Guede, libero dal 2021.
Ma la distanza tra verità processuale e percezione pubblica continua a produrre risentimenti e domande: cosa resta, nella coscienza collettiva, quando i tribunali hanno già scritto l’ultima parola?
La polemica non tocca solo Knox. Molti utenti contestano la decisione di Gwyneth Paltrow di aprire il suo show con un caso così divisivo, parlando di mancanza di tatto verso la famiglia Kercher e di “monetizzazione del dolore”. L’onda social è immediata: tra hashtag di “giustizia per Meredith” e accuse di scarsa sensibilità editoriale, si interroga la responsabilità delle piattaforme e dei volti che le guidano.
La tempistica alimenta il fuoco: in agosto è uscita su Disney+ la miniserie The Twisted Tale of Amanda Knox, girata tra Perugia e Orvieto e definita da più parti "innocentista". In parallelo, Knox consolida il proprio ecosistema mediatico – newsletter su Substack e l’app Waking Up – spostando il baricentro dal solo racconto giudiziario a un posizionamento più ampio tra attivismo, divulgazione e impresa personale.
L’industria dell’intrattenimento ha trasformato il true crime in uno dei generi più redditizi, ma il successo porta con sé un rischio: semplificare la complessità per renderla fruibile. Il caso Knox/Kercher ne è l’esempio paradigmatico. Le piattaforme che amplificano queste narrazioni hanno una responsabilità editoriale: contestualizzare, garantire pluralità di voci, tenere ferma la centralità della vittima. Non si tratta di censurare storie personali, ma di evitare che la drammatizzazione sovrasti la memoria di Meredith oppure che l’indignazione diventi un format ricorrente da alimentare a ogni nuova uscita.
A quasi vent’anni dai fatti, il dibattito non riguarda solo chi abbia il diritto di parlare, ma come lo si faccia. È legittimo interrogarsi su come le parole di Knox si posizionino rispetto alla verità giudiziaria e al dolore dei familiari, ed è altrettanto legittimo aspettarsi che media e piattaforme esercitino prudenza, evitando scorciatoie retoriche. Il punto fermo dovrebbe restare uno: il rispetto dovuto a Meredith Kercher e alla sua famiglia, bussola imprescindibile anche quando la cronaca sconfina nel pop e la conversazione diventa spettacolo.