
«Questa Madonna del Melograno è molto più di quanto possa sembrare a prima vista». Così ha esordito la professoressa Cristina Galassi, storica dell’arte e docente all’Università degli Studi di Perugia oltre che direttore della Scuola di specializzazione in beni storico artistici dell’Ateneo perugino, nel suo intervento durante il convegno “La Madonna del Melograno, furto e recupero di una tavola del XV secolo”.
Il suo approfondimento ha illuminato i numerosi strati interpretativi, stilistici e simbolici del dipinto, rivelandone la ricchezza filologica e la posizione all’interno di una fitta rete di rimandi iconografici e culturali propri dell’Italia rinascimentale.
«L’attribuzione dell’opera non è a Pierfrancesco Fiorentino, ma allo pseudo Pierfrancesco Fiorentino». Questa distinzione, sottolinea Galassi, è fondamentale. Il prefisso “pseudo” viene usato in ambito storico-artistico per indicare un autore la cui identità è incerta, ma che mostra forti affinità stilistiche con un maestro noto.
Nel caso specifico, «il corpus delle opere di Pierfrancesco Fiorentino era cresciuto a dismisura, tanto da far dubitare che un solo artista potesse averle tutte realizzate». Così la critica ha isolato un secondo autore, vicino a lui ma distinto, identificato convenzionalmente con il nome pseudo Pierfrancesco Fiorentino.
L’analisi della Galassi si è concentrata sul carattere sincretico dell’opera: «La Madonna del Melograno si ispira ai modelli figurativi di Filippo Lippi e di Pesellino, ma rielabora questi riferimenti in modo personale e creativo».

Un confronto diretto viene fatto con il celebre dipinto di Lippi del 1459, un tempo nella Cappella Medici Riccardi a Firenze, oggi alla Gemäldegalerie di Berlino: «La nostra Madonna è un dettaglio isolato da un’opera più ampia. Una sorta di ‘colmo da camera’, destinato alla devozione privata». Anche il bambino Gesù, disteso a terra, riprende l’iconografia delle visioni di Santa Brigida, dove «Maria depone il neonato sul prato, già pulito e splendente».
«Secondo i canoni moderni, potremmo definire questa produzione seriale», ha osservato storica dell'arte, «ma nel Rinascimento era una prassi normale quella di replicare modelli celebri, reinterpretandoli». Il nostro pittore lavora dunque «nella logica del ‘plagiario di genio’, creando varianti continue da fonti comuni».
Opere simili si trovano oggi in collezioni internazionali e in ognuna, la composizione viene variata: lo sfondo cambia (dorato, scuro, vegetale), compaiono angeli (ripresi da Pesellino), oppure si inseriscono dettagli floreali come le rose bianche e rosse, spesso usate dall’artista.
La Galassi ha ricostruito il dibattito critico intorno all’identità dell’autore: «Nel 1928, Mason Perkins notò l’incoerenza del corpus attribuito a Pierfrancesco. Berenson lo seguì. Federico Zeri nel 1958 parlò invece di imitatori di Lippi e Pesellino».

Negli anni ‘90, Annamaria Bernacchioni e Carlo Ricci ipotizzarono che dietro questo artista potesse esserci Piero di Lorenzo del Pratese, collaboratore di Pesellino. Un’altra teoria, formulata da Creighton Gilbert, lo identifica con Riccardo di Benedetto di Niccolò di Lornano, soprannominato “Riccardo dalle nostre donne” per la sua produzione di immagini mariane.
Uno degli elementi più evocativi del dipinto è il melograno, che dà il nome all’opera. «È un simbolo antichissimo, legato alla fertilità, al ciclo della vita, alla Passione di Cristo», ha spiegato Galassi. «I chicchi rossi richiamano il sangue di Cristo, il frutto chiuso evoca l’unità sotto la protezione divina».
Un soggetto simile compare anche nella celebre Madonna della Melagrana di Botticelli, custodita agli Uffizi, a conferma della diffusione e potenza visiva di questo simbolo nel Quattrocento fiorentino.
Galassi ha chiarito che «queste opere erano realizzate per la devozione privata, in camere da letto, studi o cappelle familiari». Non si trattava di arte “minore”, ma di una produzione destinata ad accompagnare quotidianamente la fede delle persone.
«Il tono intimo e quasi naïf di questi dipinti – ha detto – li rende ancora più toccanti. Non erano pensati per la magnificenza pubblica, ma per la contemplazione personale». Per questo, aggiunge, «non possiamo ridurre queste opere a repliche: sono variazioni su un tema spirituale».
L’intervento si è concluso con uno sguardo al futuro: «La Madonna del Melograno è ora oggetto di indagini diagnostiche da parte del Centro di Eccellenza SMAArt dell’Università di Perugia», presieduto dal professor Aldo Romani.
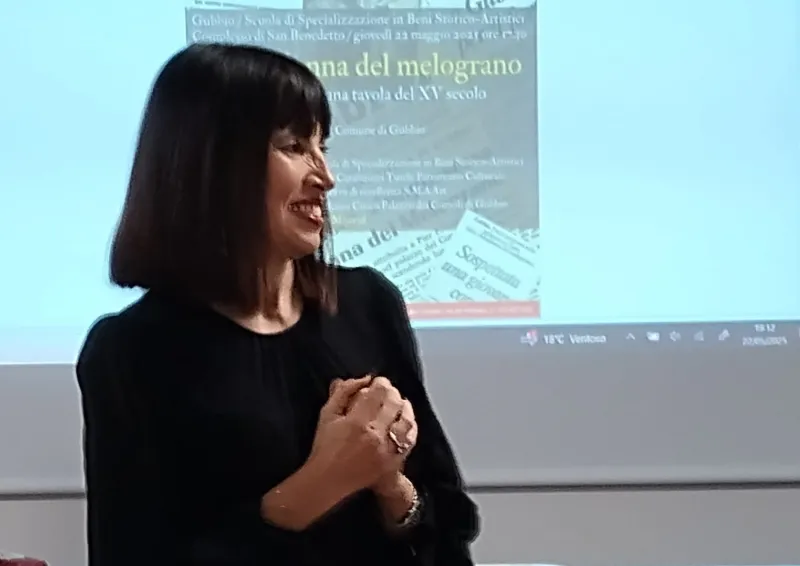
Le analisi scientifiche potranno «dirci di più sulla tecnica esecutiva, i pigmenti, il supporto ligneo e forse anche sulla mano dell’artista». Galassi ha proposto di «dedicare un numero monografico dei Quaderni del Museo Civico di Gubbio a quest’opera, alla sua storia, ai modelli che l’hanno ispirata, al furto e alla restituzione».
In chiusura, la professoressa ha ribadito l’importanza del lavoro di squadra tra università, musei, carabinieri e amministrazioni. «Il recupero della Madonna del Melograno è un’occasione non solo per restituire un bene, ma per riscoprire una storia, uno stile, una devozione».
E ha lasciato una suggestione finale: «Quella Madonna, semplice ma intensa, forse era destinata a una camera da letto. Oggi è tornata nella casa più grande di tutte: quella della comunità».